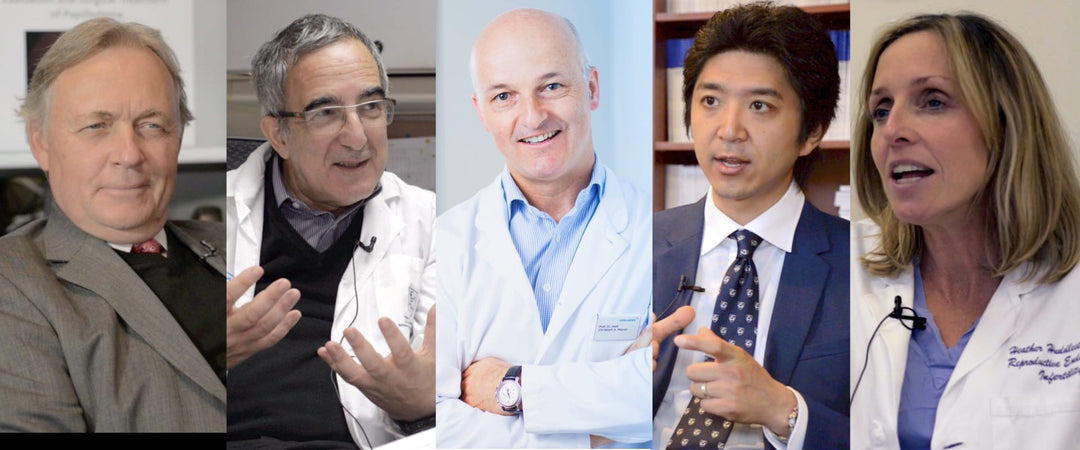Il trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche (TASCE) mostra risultati promettenti come trattamento per la sclerosi multipla grave, in particolare la forma recidivante-remittente. La procedura comporta il ripristino del sistema immunitario utilizzando le cellule staminali del paziente stesso, con studi che dimostrano una significativa stabilizzazione o miglioramento della disabilità in molti pazienti. Esiti migliori sono associati a età più giovane, durata della malattia più breve e punteggi di disabilità inferiori al momento del trattamento. Sebbene efficace, il trattamento comporta rischi tra cui malattie autoimmuni a insorgenza tardiva e richiede un'attenta selezione dei pazienti.
Trapianto di Cellule Staminali per la Sclerosi Multipla: Una Guida Completa per il Paziente
Indice
- Introduzione: Comprendere la SM e l'Evoluzione del Trattamento
- Cos'è il Trapianto Autologo di Cellule Staminali Ematopoietiche?
- Panoramica degli Studi di Ricerca
- Risultati degli Studi Clinici: Regimi Mieloablativi
- Risultati dei Regimi Linfoablativi
- Studi con Regimi di Condizionamento Misti
- Risultati degli Studi Osservazionali e Retrospettivi
- Risultati Chiave e Fattori di Successo
- Rischi di Malattie Autoimmuni dopo il Trapianto
- Implicazioni Cliniche per i Pazienti
- Limitazioni e Considerazioni degli Studi
- Raccomandazioni per i Pazienti
- Informazioni sulla Fonte
Introduzione: Comprendere la SM e l'Evoluzione del Trattamento
La sclerosi multipla (SM) è una patologia neurologica complessa che si sviluppa da una combinazione di predisposizione genetica e fattori ambientali. Ciò porta a una disfunzione del sistema immunitario in cui le cellule immunitarie dell'organismo attaccano erroneamente la guaina protettiva dei nervi nel sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale).
Negli ultimi 28 anni si sono registrati progressi notevoli nei trattamenti per la SM, in particolare per la forma recidivante-remittente (SMRR). Le prime terapie modificanti la malattia (DMT, disease-modifying therapies) approvate negli anni '90 erano i farmaci a base di interferone-beta e l'acetato di glatiramer, che hanno dimostrato come il targeting delle cellule immunitarie possa gestire efficacemente le ricadute.
La ricerca ha identificato diverse cellule immunitarie chiave coinvolte nella progressione della SM, inclusi i linfociti T (in particolare le cellule Th1 e Th17), i linfociti B, le cellule natural killer (NK) e i linfociti T regolatori (Treg). Il recente sviluppo di trattamenti mirati ai linfociti B ha ulteriormente confermato il ruolo cruciale della disfunzione del sistema immunitario nella SM.
Gli approcci terapeutici attuali includono la terapia di escalation (iniziando con trattamenti più blandi e passando a quelli più aggressivi se necessario) e l'approccio "colpisci forte e presto" utilizzando trattamenti altamente efficaci fin dall'inizio per le forme aggressive. La scelta dipende da fattori individuali del paziente e dalle caratteristiche della malattia.
Cos'è il Trapianto Autologo di Cellule Staminali Ematopoietiche?
Il trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche (aHSCT, autologous hematopoietic stem cell transplantation) è una procedura in più fasi che mira a resettare il sistema immunitario nei pazienti con SM. Il processo comprende cinque fasi chiave che i pazienti affrontano:
- Ottimizzazione pre-trapianto: Valutazione completa della salute, misure di prevenzione delle infezioni e preparazione come la terapia idratante
- Mobilizzazione delle cellule staminali: Raccolta delle cellule staminali ematopoietiche del paziente dal suo flusso sanguigno
- Condizionamento: Somministrazione di chemioterapia con o senza terapia anticorpale per eliminare le cellule immunitarie malfunzionanti
- Reinfusione delle cellule staminali: Reinserimento delle cellule staminali precedentemente raccolte per ricostruire il sistema immunitario
- Cure post-trapianto: Monitoraggio ravvicinato e cure di supporto durante la ripresa
I regimi di condizionamento variano in intensità e sono classificati dalla Società Europea per il Trapianto di Midollo Osseo e di Sangue (EBMT, European Society for Blood and Marrow Transplantation) in quattro categorie:
- Alta intensità: Distruzione completa del midollo osseo che richiede il salvataggio con cellule staminali (utilizzando irradiazione corporea totale ad alte dosi o busulfano)
- Mieloablativi a intensità intermedia: Include BEAM + ATG (carmustina, etoposide, citarabina, melfalan con globulina anti-timocita)
- Linfoablativi a intensità intermedia: Include CY + ATG (ciclofosfamide con globulina anti-timocita) o CY + ALEM (ciclofosfamide con alemtuzumab)
- Bassa intensità: Chemioterapia senza terapia anticorpale
Originariamente considerato solo per la SM progressiva in fase terminale quando proposto per la prima volta nel 1995, l'aHSCT è ora studiato per un uso precoce in pazienti con malattia aggressiva che non hanno risposto adeguatamente ai trattamenti convenzionali.
Panoramica degli Studi di Ricerca
La ricerca revisionata includeva dati di 2.574 pazienti provenienti da 46 studi condotti tra il 1999 e il 2022. Questi studi includevano sia studi clinici che studi osservazionali/retrospettivi di diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Italia, Brasile, Canada, Paesi Bassi e altri.
Di questi pazienti, 831 (32,3%) hanno partecipato a 28 studi clinici mentre 1.743 (67,7%) erano inclusi in 18 studi retrospettivi o osservazionali. Gli studi variavano significativamente nel disegno, nelle popolazioni di pazienti e nei metodi di reportistica, il che rende difficili i confronti diretti.
I periodi di follow-up variavano da 6 mesi a 11,3 anni, con diversi studi che riportavano esiti in momenti diversi. La misura di esito più comunemente riportata era la sopravvivenza libera da progressione (PFS, progression-free survival), fornita da solo 24 dei 46 studi (52,2%).
Le caratteristiche dei pazienti variavano tra gli studi, ma generalmente includevano persone con malattia attiva che era progredita nell'anno precedente al trapianto e che avevano provato almeno una terapia modificante la malattia convenzionale senza risposta adeguata.
Risultati degli Studi Clinici: Regimi Mieloablativi
Quattordici studi clinici hanno utilizzato regimi di condizionamento mieloablativi, con quattro che utilizzavano protocolli ad alta intensità e dieci a intensità intermedia. Tutti gli studi erano di fase iniziale (Fase I, II o I/II) e non randomizzati e non controllati.
I regimi ad alta intensità includevano principalmente pazienti con SM secondariamente progressiva (SMSP), con un'eccezione (studio Atkins et al. 2016) che includeva numeri uguali di pazienti con SMRR e SMSP. Questi pazienti generalmente avevano punteggi di disabilità più alti, con punteggi EDSS basali che variavano da 6 a 7.
Lo studio Atkins del 2016 ha mostrato i migliori risultati tra i regimi ad alta intensità, con il 70% dei pazienti che raggiungeva la stabilità della malattia. Altri studi hanno riportato tassi di stabilità del 54% (Nash et al. 2003), 19% (Burt et al. 2003) e 21% (Samijn et al. 2006). I tassi di miglioramento variavano dal 4% al 14% tra questi studi.
Notabilmente, lo studio Nash et al. ha seguito i pazienti per la durata più lunga (follow-up mediano di 12 anni), fornendo dati preziosi a lungo termine sugli esiti del trattamento. Questi risultati suggeriscono che, sebbene i regimi ad alta intensità possano fornire benefici, potrebbero essere più adatti per specifiche popolazioni di pazienti.
Risultati dei Regimi Linfoablativi
Gli studi controllati randomizzati hanno fornito evidenze di qualità superiore per i regimi linfoablativi. Lo studio Burt et al. del 2019 ha confrontato l'aHSCT utilizzando ciclofosfamide e ATG contro le terapie modificanti la malattia convenzionali in 110 pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente.
Questo studio ha mostrato risultati notevoli: dopo tre anni, il 94,5% dei pazienti trapiantati è rimasto stabile o migliorato, rispetto a solo il 25,9% nel gruppo di terapia convenzionale. Il punteggio EDSS medio è migliorato da 2,3 a 1,3 nel gruppo trapianto, mentre è peggiorato da 2,3 a 2,9 nel gruppo di controllo.
Anche gli studi non randomizzati con regimi linfoablativi hanno mostrato esiti promettenti. Lo studio Burt et al. del 2009 ha riportato che il 100% dei pazienti era stabile o migliorato a tre anni, con l'EDSS migliorato da 3,1 a 1,3. Altri studi hanno mostrato tassi di miglioramento che variavano dal 32,1% al 90,5%.
Questi risultati dimostrano costantemente che i regimi linfoablativi a intensità intermedia possono produrre miglioramenti clinici significativi, in particolare per pazienti con SMRR e punteggi di disabilità basali più bassi.
Studi con Regimi di Condizionamento Misti
Alcuni studi hanno utilizzato regimi di condizionamento eterogenei che includevano protocolli di diversa intensità. Questi studi hanno fornito ulteriori approfondimenti su come l'intensità del trattamento influisce sugli esiti in vari tipi di SM.
Lo studio Fassas et al. del 2002 includeva pazienti con SM sia progressiva che recidivante utilizzando regimi ad alta e media intensità. Hanno riscontrato che il 44% dei pazienti è migliorato e il 44% è rimasto stabile, con un tasso di sopravvivenza libera da progressione del 75% a 3,5 anni.
Lo studio Fassas et al. del 2011 con follow-up più lungo (15 anni) ha mostrato che il 6% dei pazienti è migliorato e il 20% è rimasto stabile, con una sopravvivenza libera da progressione del 25% a 15 anni. Ciò dimostra che, sebbene i benefici possano durare a lungo, la progressione della malattia può ancora verificarsi su periodi estesi.
Questi studi con regimi misti evidenziano che l'efficacia del trattamento non dipende chiaramente solo dall'intensità del condizionamento, e che i fattori di selezione del paziente possono essere determinanti più importanti per il successo.
Risultati degli Studi Osservazionali e Retrospettivi
Gli studi osservazionali e retrospettivi includevano numeri più elevati di pazienti e fornivano dati del mondo reale sugli esiti dell'aHSCT. Questi studi hanno confermato i risultati degli studi clinici aggiungendo approfondimenti pratici dalla pratica clinica più ampia.
Lo studio Mariottini et al. del 2018 su 125 pazienti ha mostrato che il 22% è migliorato e il 22% è rimasto stabile, con esiti particolarmente buoni per i pazienti con SMRR. Lo studio multicentrico Muraro et al. del 2017 su 281 pazienti ha riscontrato una possibile riduzione della disabilità nel 66% dei pazienti, con il 73% che non mostrava evidenza di attività di malattia a due anni.
Lo studio Boffa et al. del 2022 su 210 pazienti ha dimostrato che l'EDSS medio è diminuito di 0,90 punti per anno nei pazienti con SMRR dopo il trapianto. Ciò rappresenta un miglioramento funzionale significativo che potrebbe impattare sostanzialmente la qualità della vita.
Questi studi del mondo reale forniscono forti evidenze a supporto che l'aHSCT può essere efficace al di fuori di condizioni strettamente controllate di studio, sebbene un'attenta selezione dei pazienti rimanga cruciale per esiti ottimali.
Risultati Chiave e Fattori di Successo
La ricerca ha identificato costantemente diversi fattori associati a migliori esiti dopo l'aHSCT. I pazienti che hanno beneficiato di più tipicamente avevano:
- Punteggi di disabilità basali più bassi: Punteggi EDSS inferiori a 5,5-6,0 predicevano migliori esiti
- Sclerosi multipla recidivante-remittente: I pazienti con SMRR rispondevano meglio delle forme progressive
- Età più giovane: Generalmente sotto i 45 anni
- Durata della malattia più breve: Meno anni dalla diagnosi
- Malattia infiammatoria attiva: Evidenza di recente attività di malattia
Questi fattori si allineano con le linee guida per la selezione dei pazienti proposte dalla Società Europea per il Trapianto di Midollo Osseo e di Sangue (EBMT). Le evidenze suggeriscono che un intervento precoce nel decorso della malattia, prima che si accumuli una disabilità significativa, offre la migliore opportunità per il successo del trattamento.
Interessantemente, alcuni studi hanno anche riportato esiti promettenti per pazienti con SM secondariamente progressiva (SMSP), in particolare quelli con malattia attiva. Ciò suggerisce che l'aHSCT potrebbe valere la pena essere considerato per alcuni pazienti con SM progressiva che continuano a sperimentare attività infiammatoria.
Rischi di Malattie Autoimmuni dopo il Trapianto
Un risultato importante attraverso multiple studi è stato lo sviluppo di nuove malattie autoimmuni seguenti l'aHSCT. Una proporzione significativa di pazienti ha sviluppato condizioni autoimmuni dopo il trattamento, il che rappresenta una considerazione importante quando si valutano rischi e benefici del trattamento.
Il rischio è apparso più elevato con i regimi contenenti alemtuzumab. Le complicanze autoimmuni includevano disturbi tiroidei, piastrinopenia immune e altre condizioni autoimmuni. Queste si sono generalmente sviluppate da mesi ad anni dopo il trapianto.
Questo fenomeno suggerisce che, sebbene il trapianto autologo di cellule staminali ematopoietiche (TCSEa) possa resettare efficacemente il sistema immunitario per ridurre l'attività della sclerosi multipla, potrebbe anche svelare o scatenare altre tendenze autoimmuni in individui suscettibili. Un monitoraggio regolare a lungo termine è essenziale per rilevare e trattare queste potenziali complicanze.
Il rischio di complicanze autoimmuni deve essere bilanciato con i potenziali benefici del trattamento, specialmente per i pazienti con sclerosi multipla aggressiva che non ha risposto alle terapie convenzionali.
Implicazioni per i Pazienti
Per i pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente altamente attiva che non ha risposto adeguatamente ai trattamenti convenzionali, il TCSEa rappresenta un'opzione terapeutica potenzialmente trasformativa. La procedura offre la possibilità di un controllo a lungo termine della malattia senza terapia farmacologica continuativa, con molti pazienti che raggiungono l'assenza di evidenza di attività di malattia per anni dopo il trattamento.
Le evidenze suggeriscono che un intervento precoce, prima che si accumuli una disabilità significativa, offre i migliori risultati. I pazienti con punteggi EDSS più bassi (tipicamente inferiori a 5,5-6,0), età più giovane e durata di malattia più breve tendono a rispondere meglio al trattamento.
Sebbene studiato principalmente nella sclerosi multipla recidivante-remittente, alcuni pazienti con sclerosi multipla secondariamente progressiva attiva potrebbero trarre beneficio dal TCSEa. Ciò è particolarmente rilevante per i pazienti progressivi che continuano a presentare recidive o evidenza di attività infiammatoria alla risonanza magnetica.
Il trattamento comporta rischi significativi, inclusi infezioni durante il periodo di ricostituzione immunitaria, infertilità e sviluppo di altre malattie autoimmuni. Questi rischi devono essere discussi attentamente con i professionisti sanitari quando si valutano le opzioni terapeutiche.
Limitazioni e Considerazioni dello Studio
L'attuale base di evidenze presenta diverse importanti limitazioni che i pazienti dovrebbero comprendere. La maggior parte degli studi era non randomizzata e non controllata, il che significa che mancavano gruppi di confronto che ricevevano trattamenti alternativi. Ciò rende difficile stabilire definitivamente la superiorità rispetto ad altre terapie ad alta efficacia.
Si è osservata un'eterogeneità significativa nei regimi di condizionamento, nelle popolazioni di pazienti e nella segnalazione degli esiti tra gli studi. Questa variabilità rende difficile confrontare direttamente i risultati e identificare il protocollo terapeutico ottimale.
I dati a lungo termine oltre i 10-15 anni sono limitati, quindi gli effetti a lunghissimo termine del TCSEa rimangono non completamente compresi. Inoltre, la maggior parte degli studi si è concentrata su pazienti più giovani (tipicamente sotto i 45 anni), quindi la sicurezza e l'efficacia nei pazienti più anziani con sclerosi multipla sono meno consolidate.
Infine, gli studi generalmente escludevano pazienti con comorbidità significative o disabilità avanzata, quindi i risultati potrebbero non applicarsi a tutti i pazienti con sclerosi multipla. Sono necessari più studi randomizzati controllati per stabilire linee guida terapeutiche definitive.
Raccomandazioni per i Pazienti
Se stai considerando il TCSEa per la sclerosi multipla, ecco i passi importanti da compiere:
- Cerca una valutazione in un centro specializzato: Rivolgiti a centri con ampia esperienza sia nella cura della sclerosi multipla che nel trapianto di cellule staminali
- Ottieni una valutazione completa: Assicurati una valutazione approfondita del tuo sottotipo di sclerosi multipla, dell'attività di malattia, del livello di disabilità e dello stato di salute generale
- Discuti i tempi: Considera se un intervento precoce potrebbe essere più benefico che aspettare fino a stadi più avanzati della malattia
- Comprendi i rischi: Rivedi attentamente le potenziali complicanze, incluse infezioni, infertilità e complicanze autoimmuni
- Valuta le alternative: Discuti altre terapie modificanti la malattia ad alta efficacia che potrebbero essere appropriate per la tua situazione
- Pianifica la recupero: Prepara il periodo di recupero prolungato e i necessari sistemi di supporto
- Organizza il follow-up a lungo termine: Assicurati che siano previsti piani per il monitoraggio continuo dopo il trattamento
Il TCSEa rappresenta un'opzione terapeutica promettente ma seria che richiede un'attenta considerazione e cure mediche specializzate. Sebbene non sia appropriato per tutti i pazienti con sclerosi multipla, può offrire benefici significativi per individui accuratamente selezionati con malattia aggressiva che non ha risposto ai trattamenti convenzionali.
Informazioni sulla Fonte
Titolo Originale dell'Articolo: The current standing of autologous haematopoietic stem cell transplantation for the treatment of multiple sclerosis
Autori: A. G. Willison, T. Ruck, G. Lenz, H. P. Hartung, S. G. Meuth
Pubblicazione: Journal of Neurology (2022) 269:3937–3958
Ricevuto: 4 febbraio 2022 / Revisionato: 2 marzo 2022 / Accettato: 3 marzo 2022 / Pubblicato online: 11 aprile 2022
Questo articolo a misura di paziente si basa su ricerche sottoposte a revisione paritaria pubblicate sul Journal of Neurology. Mantiene tutti i dati e i risultati originali rendendo le informazioni accessibili a pazienti e caregiver.